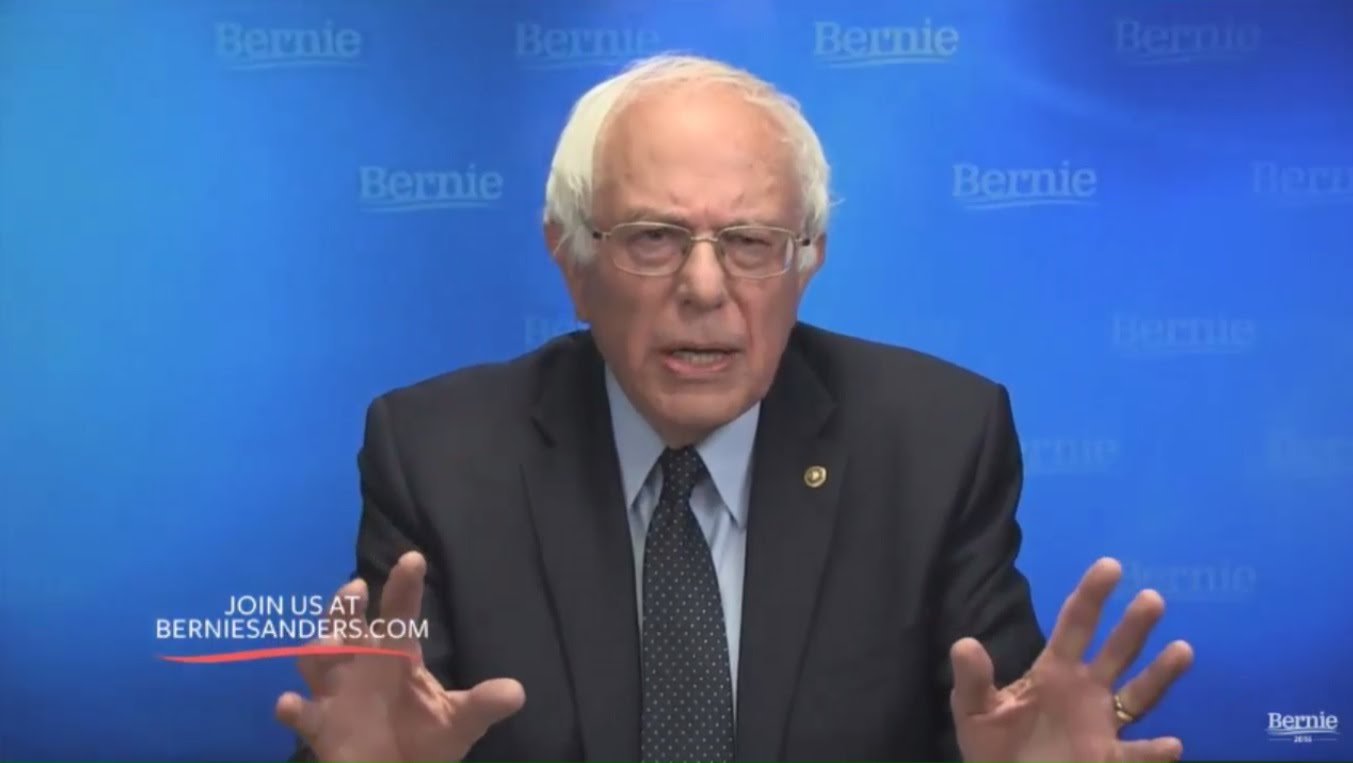La tentazione di fare un confronto tra due film della Festa del cinema di Roma come Sole cuore amore, di Daniele Vicari, e Maria per Roma, di Karen Di Porto (al suo primo lungometraggio e anche attrice protagonista nei panni di Maria), è davvero irresistibile. In entrambi si parla di precariato, il punto di vista è quello di una donna e l’ambientazione è romana. Ciò che è davvero interessante, però, è il modo in cui sono gestiti questi tre elementi, tanto diverso da rendere i due film praticamente estranei tra loro, a dispetto di una matrice comune. In Sole cuore amore Isabella Ragonese ha origine proletaria, è orfana, vive fuori città, mantiene la famiglia da sola, è costretta a ritmi sovrumani pur di conservare il posto di lavoro in un bar della periferia e la sua è essenzialmente una storia tragica; Maria, invece, viene da una famiglia medio-alto borghese ormai in decadenza, lavora come key-holder per un’agenzia che affitta case ai turisti, si muove sullo sfondo di un luminoso centro storico, non ha una famiglia sulle spalle – se si esclude la cagnetta che porta sempre con sé –, fatica molto per mantenere in piedi sia il suo impiego sia la difficile carriera di attrice (unica cosa che le interessa davvero): la sua è un’esistenza agrodolce.
La commedia di Karen Di Porto, ambientata nell’arco di una giornata, offre lo spaccato di un lato molto particolare del precariato, certamente ben noto alla regista (che non ha esitato a mettere in gioco materiali autobiografici). Gli attori, a quanto pare, non sono soltanto delle star miliardarie che non sanno come spendere tutti i loro soldi. C’è anche un’altra dimensione, più piccola e marginale, che probabilmente ingloba la maggior parte degli attori o aspiranti tali: quella che impone una doppia vita e un doppio lavoro pur di mandare avanti (con grande incertezza) la professione artistica. Alcuni desistono, come Cesare, l’amico di Maria che pur di guadagnare arriva a travestirsi da Gesù per poi farsi fotografare con i turisti (entrando in contatto con la “mafia” dei centurioni lungo i Fori Imperiali). Altri provano tra alti e bassi a conciliare le due cose. La giornata di Maria segue questo programma, tra continui giri con il motorino alla caccia dei turisti a cui dare le chiavi e un provino che, se dovesse andare bene, potrebbe cambiare le cose.
Il film si regge su una struttura frammentaria, con una serie di scenette tenute insieme dalla presenza della protagonista (un impianto che ricorda il cinema del primo Nanni Moretti, orientato qui in una direzione molto diversa). Il precariato in cui sguazza Maria non è quello devastante raccontato da Daniele Vicari; la prospettiva è diversa perché diversa è la situazione di partenza (come dire che ci sono tante forme di precariato possibili). In Maria per Roma (il cui titolo rimanda non solo al girovagare per la città, ma anche ad un antico proverbio romano, «cercare Maria per Roma», usato per indicare la difficoltà di trovare qualcosa, come una specifica donna di nome Maria in una città enorme dove tante donne si chiamano, o si chiamavano, così) si avverte il senso di abbandono di una generazione che non può più contare sulla famiglia e sulla stabilità guadagnata dai genitori (i quali non possono fare nulla: il padre di Maria è morto – compare in un paio di occasioni alla maniera di un fantasma a simboleggiare una stabilità perduta – e la madre, che rimpiange i floridi anni Novanta, sta assistendo impotente al fallimento del suo attività commerciale). Intanto, Roma rimane sullo sfondo, soffocata dai suoi abitanti e dai turisti (che danno da vivere ai personaggi del film e alla città stessa), indifferente alle problematiche di ciascuno ma allo stesso tempo accogliente come la casa in cui si è nati e cresciuti.